
- +39 -3516014250
- info@mysomm.it
- Lun-Ven 9 - 21.30
- Home
- Chi Siamo
- Wine Education
- Blog
- Eventi
- Consulenza
- Contatti
- Shop
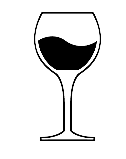
I nostri corsi
Scegli il corso che fa per te
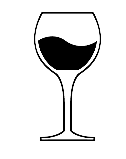
Scegli il corso che fa per te
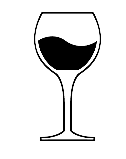
Scegli il corso che fa per te
Sul tema del “legno” si potrebbero scrivere interi libri, qualcuno interessante, molti noiosi e la maggior parte inutili. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo a disposizione un solo libro e dobbiamo sfruttarlo al meglio per disegnare un quadro completo (o almeno ci proveremo) che tocchi in maniera esaustiva i principali temi indispensabili ad intraprendere la complessa e affascinante via che porta alla conoscenza del vino. La premessa mi consente di auto giustificarmi se riassumerò, in maniera sintetica e non del tutto esaustiva il “magico” potere del legno:
Perché si pratica l’affinamento del vino in botti di legno? Tutti noi abbiamo almeno un amico che millanta un’esperienza da assaggiatore grazie all’utilizzo noioso e prevedibile del termine “barricato”. Facciamo chiarezza: il legno è un materiale poroso. La porosità del legno garantisce al vino una giusta micro-ossigenazione che notoriamente garantisce al vino stesso un’evoluzione virtuosa gravida di aromi terziari tanto cari agli amici d’oltreoceano. Il legno è anche un materiale aromaticamente attivo; la “botte piccola” cede di più e più velocemente, la “botte grande” cede meno e necessita di più tempo. Il legno permette al vino di ossigenarsi in maniera idonea durante la sua maturazione a patto che il vino stesso accolga anche i suoi dolci tannini gallici e tutte le sensazioni empireumatiche che la tostatura (più o meno spinta) praticata sulle assi (di rovere nella maggior parte dei casi) in fase di assemblaggio, inevitabilmente, cede al nettare di Bacco.
Facciamo un piccolo passo indietro: l’uso del cosiddetto tannino di galla risale a molti anni fa, quando veniva utilizzato come unico mezzo per la chiarificazione dei mosti e come rimedio all’ipercollatura dei vini bianchi (e tutto questo fino a una ventina d’anni fa). Il tannino del legno è una molecola idrolizzabile (a seguito di idrolisi acida libera glucosio, acido gallico o ellagico) presente nelle galle del legno di quercia, castagno, acacia e tara. I tannini in questione reagendo con l’ossigeno preservano il mosto dalle ossidazioni e stabilizzano la materia colorante fornendo un ausilio importante ed utile al processo di affinamento e stabilizzazione. Abbiamo detto però che il legno è anche un materiale aromaticamente attivo e che quindi, cedendo al mosto molecole aromatiche proprie, imprime al vino un profilo organolettico caratterizzante.
Passiamo alla traduzione: il legno non è né buono né cattivo: è una scelta. Se vogliamo assaporare l’essenza primitiva e originale di un vitigno dovremmo preferibilmente rinunciare al legno. Se, a partire da un vitigno che ci interessa conoscere, vogliamo vivere anche l’esperienza di aromi e sapori terziari (che potremmo definire complessi), allora dovremmo concedere al legno di svolgere il suo lavoro al meglio. Se nel vino ricerchiamo la ricchezza delle sensazioni tipiche della tostatura, del caffè, del cioccolato e dell’affumicato, allora diamo via libera al legno. Se il nostro gusto purista ricerca l’essenza primigenia del vitigno, le sue peculiarità e la sua verginità adamitica respingiamo il legno e accendiamo il semaforo verde al cemento e all’acciaio…. o semplicemente al vetro. Perché abbiamo intitolato questo paragrafo “il mito del legno”? Semplicemente perché non esiste un mito del legno (tranne che per i nostri amici americani). Esistono scelte: esiste la complessità e l’ampiezza del legno ed esiste la purezza varietale e primitiva della rinuncia al legno. Esiste il calore rassicurante di uno scrigno vellutato ed esiste il colpo tagliente e sorprendente della nudità. Quale luogo comune vogliamo sfatare? La supremazia di un vino non dipende dall’utilizzo del legno. Il legno può rendere interessante un vitigno debole così come può ammutolire vitigni nobili e ricchi di “territorialità”.